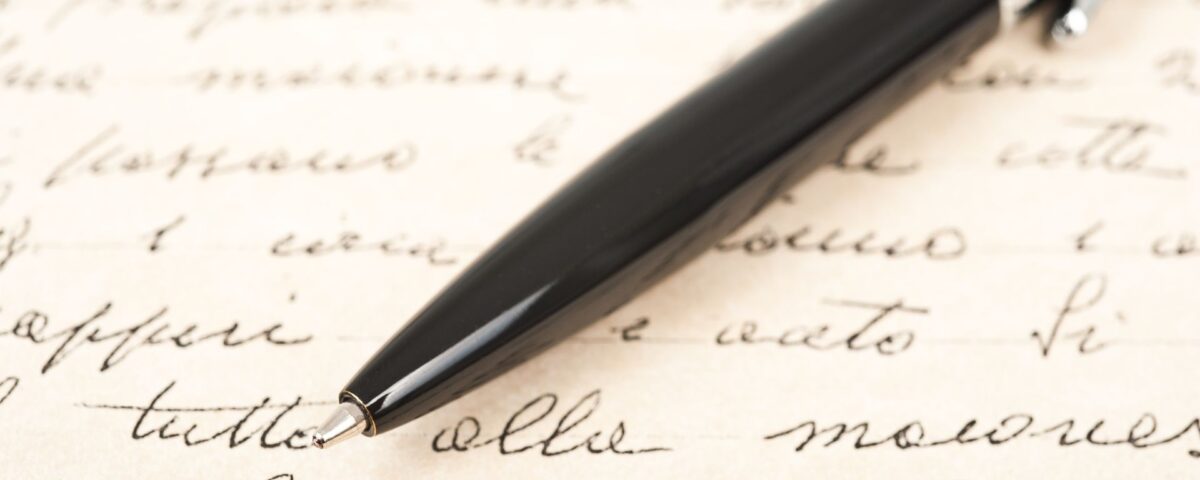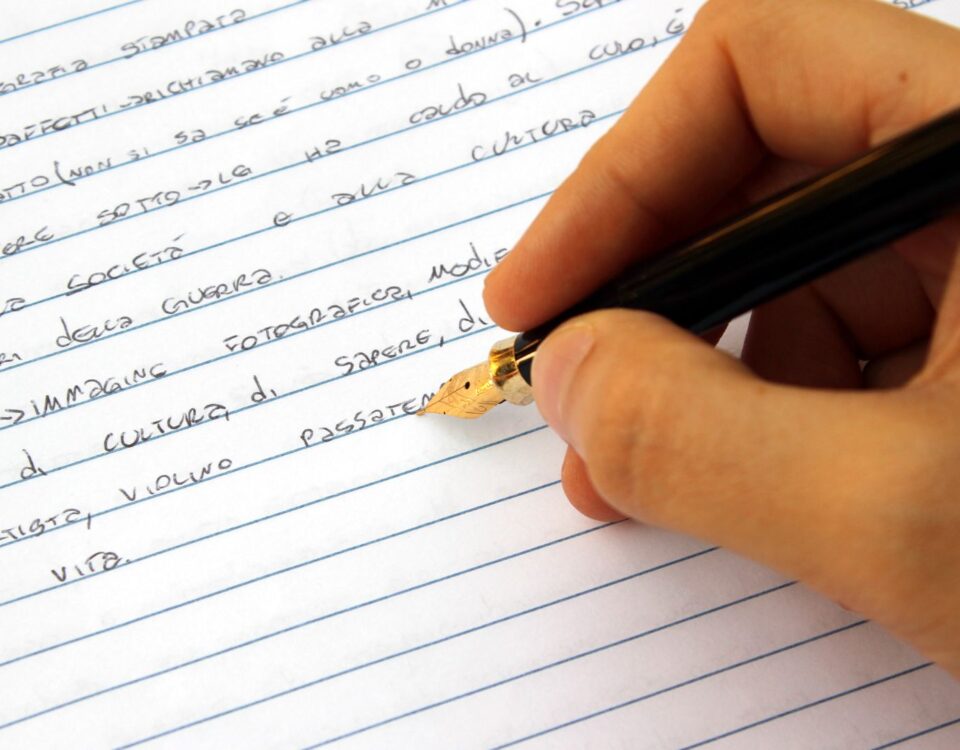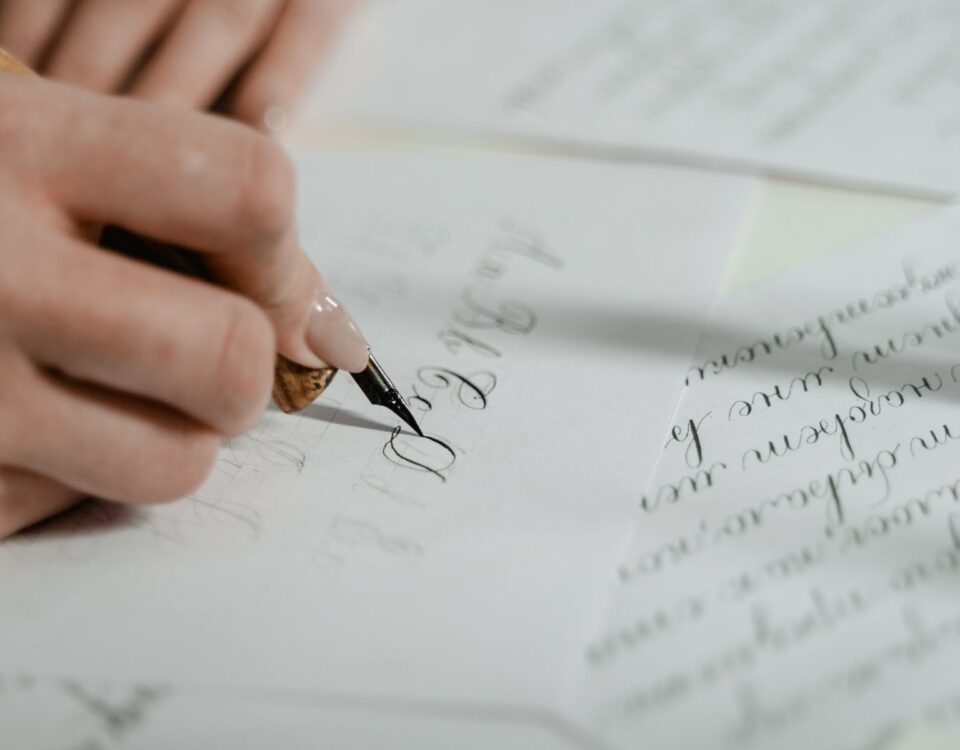ALCUNI INDICI GRAFOLOGICI PER VALUTARE LA GENUINITÀ DI UN TESTAMENTO OLOGRAFO

Quando una firma può essere considerata un’imitazione e quindi un falso?
Dicembre 18, 2024
La Scrittura: un’Espressione Cerebrale Indipendente dall’Organo Scrivente
Aprile 9, 2025Il testamento olografo è una particolare tipologia di testamento in cui il testatore redige di proprio pugno le sue ultime volontà, riportandole integralmente per iscritto, accompagnandole con la data completa e la sua firma, come previsto dalla legge. Per il grafologo peritale, le informazioni sul de cuius sono fondamentali: età, stato di salute, livello culturale e professione, tra le altre, costituiscono elementi essenziali per comprendere a fondo il contesto in cui è stato redatto il testamento e, conseguentemente, per esprimere un giudizio accurato.
Uno degli aspetti principali da considerare è l’età del de cuius. La scrittura evolve con il tempo, subendo inevitabilmente modificazioni nel corso della vita. La grafia di una persona giovane è caratterizzata da maggiore fluidità ed elasticità rispetto a quella di un anziano, in cui prevalgono indurimenti nei tratti grafici, riduzioni delle spinte espansive, tremori naturali e frammentazioni. Questi cambiamenti, tipici dell’invecchiamento, riflettono una progressiva perdita di coordinazione motoria e di stabilità pressoria, aggravate in molti casi da condizioni patologiche specifiche.
Lo stato di salute del de cuius è un altro elemento cruciale. Alcune patologie, come il morbo di Parkinson, influenzano significativamente la scrittura, generando micrografia, riduzione delle ampiezze e tremori specifici. Tuttavia, è importante ricordare che gli effetti delle malattie possono variare da persona a persona, e una conoscenza dettagliata delle condizioni cliniche del testatore può aiutare il grafologo a distinguere tra fenomenologie naturali e segni di artificiosità.
Anche il livello culturale e la professione del de cuius giocano un ruolo significativo. La capacità espressiva e le modalità di scrittura di una persona sono strettamente correlate al suo bagaglio culturale e alle influenze della sua attività lavorativa. Questi elementi possono determinare specifici condizionamenti grafici che non devono essere sottovalutati, ma anzi contestualizzati nell’analisi.
Un esempio interessante riguarda le situazioni in cui il testatore ha subito un infortunio o ha utilizzato una mano non abituale per scrivere il testamento. In questi casi, la scrittura può apparire insicura o irregolare, suscitando dubbi sulla sua autenticità. Tuttavia, tali peculiarità non devono essere interpretate immediatamente come artificiose, ma vanno analizzate alla luce delle circostanze oggettive.
Un aspetto centrale nell’analisi del testamento olografo è la valutazione della spontaneità della scrittura. La scrittura spontanea si caratterizza per coerenza e fluidità, mentre una grafia artificiosa presenta elementi di forzatura, come variazioni nelle ampiezze, nella velocità e nella pressione. Gli elementi di contraddizione intrinseca, come incoerenze stilistiche o variazioni improvvise nel tratto, sono segnali importanti che possono indicare la falsificazione del documento.
Tra i segnali più evidenti di artificiosità, emergono le cosiddette variazioni di ruolo, spesso legate a parole o locuzioni non comuni nella scrittura abituale del testatore. Ad esempio, termini come “nomino erede” o “usufrutto” possono essere riprodotti in modo incoerente rispetto al resto del testo, suggerendo che siano stati inventati ex novo dall’imitatore.
Anche gli aspetti formali, come l’impaginazione, la lunghezza del testo e il modo di andare a capo, forniscono indizi preziosi. Testamenti eccessivamente sintetici o, al contrario, insolitamente lunghi possono rappresentare un campanello d’allarme. Inoltre, variazioni grafiche legate al tipo di carta, inchiostro o strumento di scrittura devono essere considerate nel contesto delle condizioni oggettive e soggettive del testatore.
Un elemento fondamentale nell’analisi è lo studio della qualità del tratto grafico. Intensità, ampiezza e velocità devono essere coerenti tra loro, riflettendo il ritmo scrittorio individuale. Quando tali caratteristiche non si accordano, emergono segnali di artificiosità. Per esempio, nel morbo di Parkinson, il movimento grafico appare frammentato e caratterizzato da piccoli scatti, ma se queste peculiarità sono accompagnate da una pressione anomala o da tratti incoerenti, si potrebbe ipotizzare un tentativo di imitazione.
Infine, la naturalezza della scrittura rappresenta un aspetto imprescindibile. Una grafia autentica riflette la natura temperamentale del soggetto, anche se condizionata dall’esperienza di vita e dalle circostanze contingenti. Al contrario, una grafia artificiosa manca di quella coerenza dinamica e ritmica che è propria di ogni scrittura genuina.
In conclusione, l’analisi del testamento olografo richiede al grafologo una conoscenza approfondita delle variabili che influenzano la scrittura e un approccio critico nella valutazione di tutti gli elementi presenti. Solo attraverso un’indagine accurata e contestualizzata è possibile distinguere tra autenticità e falsificazione, garantendo la salvaguardia del valore legale del documento e l’equità della sua corretta interpretazione.
Dott.ssa Romina Casella